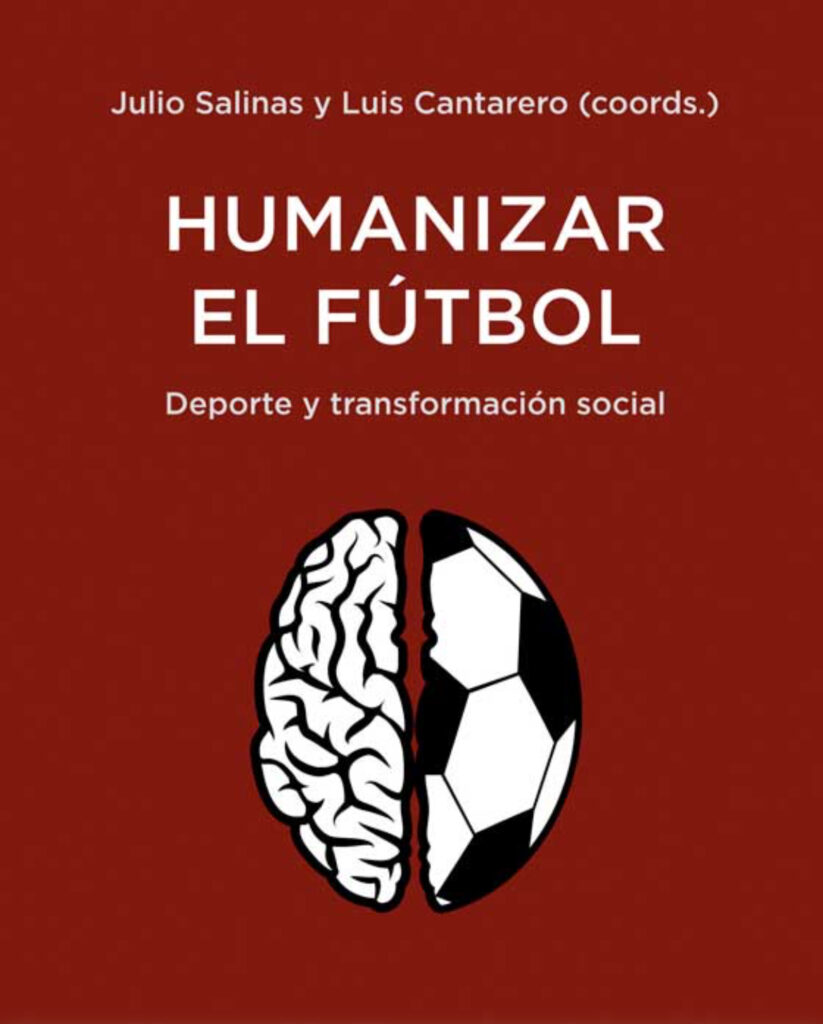Caterina Gozzoli, Chiara D’Angelo ed Edgardo Zanoli docenti a diverso titolo presso l’Alta scuola di Psicologia Agostino Gemelli-Università Cattolica di Milano, hanno partecipato alla stesura del libro in copertina “HUMANIZAR EL FÚTBOL – Deporte y Trasformacion Social”, scrivendo un capitolo che presentiamo in questo blog suddiviso in quattro parti. Il libro non è ancora stato tradotto in lingua italiana.
L’UMANIZZAZIONE COME PROCESSO
Abbiamo lavorato a lungo con club professionistici di sport di squadra, chi coordinando gli staff tecnici, chi supervisionando gli psicologi e gli atleti nelle residenze, chi avendo una funzione manageriale per avviare un lavoro congiunto attraverso la formazione delle risorse umane.
Ne abbiamo tratto che rischi e possibilità di umanizzazione e disumanizzazione si snodano continuativamente nel tempo e sono diversi a seconda dei contesti; infatti, a seconda della cultura organizzativa e del tipo di management, possono presentarsi secondo modalità e manifestazioni differenti.
Ecco perché è più utile immaginare l’umanizzazione versus la disumanizzazione come esito di tanti passaggi e intrecci nel tempo. A seguire racconteremo di alcune forme di disumanizzazione riscontrate, che non hanno la pretesa di essere esaustive, ma che individuano rischi e possibilità di intervento.
Primo fra tutti, presentiamo quello che si potrebbe definire rischio di sradicamento negato: gli atleti, spesso adolescenti, arrivano in un club sportivo lontano da casa, lasciando famiglia e amici; partono con un desiderio, un sogno, che li motiva a sacrificare gli affetti e le modalità rassicuranti a cui erano precedentemente abituati. Questa condizione è paragonabile ad una migrazione, a prescindere dalla distanza da casa, tale allontanamento rappresenta un momento di cambiamento, che segna la loro storia biografica e fornisce una misura dell’investimento emotivo che sottostà a questa scelta.
Vissuti di perdita ed incertezza, unitamente al momento evolutivo delicato in cui gli adolescenti si trovano, caratterizzano tale trasferimento come un momento di transizione totale, a livello personale, professionale e sociale.
È altresì frequente che nei club si evidenzi il rischio di trascurare le dinamiche evolutive che sono tipiche di questa fase di vita. Alcuni ragazzi, inizialmente molto motivati e talentuosi, spesso manifestano problematiche di rendimento o di atteggiamento.
Non è difficile che questi episodi vengano del tutto ignorati o sminuiti, invece di essere accolti e compresi in un’ottica in cui il benessere della persona segue una logica olistica e soggettiva, non scindibile in componenti autonome e separate corrispondenti ai loro diversi ruoli sociali.
Vale a dire che il benessere che può derivare dalla gratificazione nella buona riuscita sportiva, non compensa automaticamente l’insoddisfazione o la sofferenza che un giocatore può sperimentare nel contesto familiare.
A supporto di questa teorizzazione, si riscontra che alla base di trasformazioni nel rendimento o nella motivazione sportiva, ci sono spesso cause relazionali.
Evidente nella storia di Alex: la madre viene ricoverata in psichiatria per un episodio di grave depressione, ed Alex per paura di deludere il mister e i compagni che contavano su di lui per vincere la finale, non esprime il suo desiderio di correre a casa nè tantomeno la sua fatica. Durante la partita appare assente e disconnesso. È evidente che questa condizione emotiva abbia influenzato la sua performance.
Un secondo esempio riguarda Abdel un calciatore di origine marocchina con doppia cittadinanza: il padre insiste affinché il ragazzo giochi con la nazionale del Marocco, mentre il club desidera che giochi con la nazionale italiana. Il risultato di questo conflitto destabilizza il giocatore, che, secondo l’allenatore, si presenta ogni domenica più nervoso e aggressivo durante la partita.
Questi sono solo alcuni esempi che raccontano dell’impatto di fattori evolutivi ed emotivi sul rendimento atletico, di cui spesso le organizzazioni non si prendono cura. Come se non fosse lecito essere uomini, donne, giovani con emozioni… il tema non è oscurare né negare il tema della importanza della prestazione ma di offrire da un lato occasioni di ascolto o supporto laddove richiesto dai giovani, e di trattare quanto sia importante per un futuro giocatore saper esprimere, gestire e regolare la propria emotività.
Anche il non accompagnamento all’esposizione dei media rappresentano una minaccia potenziale: l’esposizione precoce del talento, la generazione rapida di alte aspettative e della notorietà ad esse associata, può influenzare profondamente la percezione e la valutazione di sé sia nella valorizzazione (sono un vincente) sia nella devalorizzazione (sono un fallito)…
Un ulteriore rischio, che interessa sia gli allenatori che i giocatori, concerne la cultura della performance, dell’esito più che del processo e l’assenza di una cultura collaborativa e della innovazione/crescita in cui l’errore è parte del processo di apprendimento: nella maggior parte dei casi osservati gli atleti non si sentono liberi di condividere punti di vista personali, riflessioni, ad indicare un timore di giudizio o la paura di sbagliare.
L’errore e la divergenza non vengono considerati fonte di miglioramento, ma come una deviazione dall’ordine stabilito, una perdita di tempo. Implicitamente, inoltre, si stabilisce e rinforza così una cultura dell’asimmetria di ruoli; il management si dichiara aperto alla collaborazione, ma nella pratica si riscontrano modalità ispirate a principi gestionali ingegneristici: gestione rigida dei tempi, specializzazioni di ruolo, focalizzazione sull’esito, sull’individualità.
Un aspetto rilevante è il tipo di proposta metodologica: a quale idea di apprendimento facciamo riferimento?
Quale importanza viene data alla ripetizione dei gesti, agli automatismi, all’imitazione o alla interpretazione e all’esperienza vissuta insieme ? Come vengono preparati gli allenamenti? Quali spazi di esperienza ludica sono pensabili? Quale spazio viene consentito alla creatività , alla verifica congiunta di ciò che viene proposto ? Quante volte chiediamo ai giocatori quello che vedono e “sentono” dentro il campo? In sostanza quanto partecipano attivamente al loro percorso e quanto ne sono realmente a conoscenza e convinti i giocatori?
Allenare (in quest’ottica) non è chiedere ai giocatori di ripetere pedissequamente ciò che l’allenatore vuole, ma creare situazioni nelle quali il giocatore può effettuare scelte.
Attraverso l’allenamento in situazione il giocatore sviluppa conoscenza e scopre relazioni con i compagni che sono tanto tecniche quanto socio relazionali… spesso si osservano sessioni di allenamento in cui i gesti vengono eseguiti con estremo ordine e armonia ma ove non c’è variabilità possibile e si è molto lontani dalla realtà in cui esistono avversari, porta, pallone e spazi …come immaginiamo la trasferibilità di ciò che insegniamo?
Tanto più ci allontaniamo dal gioco del calcio nella sua complessità scomponendo… tanto più la trasferibilità è poco percorribile. Il passaggio da allenatore/istruttore che ordina e i giocatori eseguono ad un allenatore/formatore che si mette al pari nel rapporto di relazione con il giocatore, in un ciclo bidirezionale di continuo apprendimento diventa necessario. L’allenatore facilitatore di processi, che esprime la sua competenza primaria nel sostare dentro la complessità e che quindi accetta la perdita del controllo (sia in termini concreti visibili sul campo, che in termini di profondo cambiamento interiore) diventa la possibile espressione del professionista umanizzante. In un solo concetto si potrebbe parlare di favorire l’autoesigenza (cit. Ettore Messina in Youtube Discorso sulla autoesigenza).
Si osserva, inoltre, frequentemente un basso livello di coordinamento tra parti organizzative, ogni allenatore si occupa della propria squadra, all’interno della quale cerca di sviluppare la professionalità individuale di ogni giocatore, ma non la capacità collettiva; le riunioni hanno prevalentemente scopo informativo e la competizione esaspera le relazioni e il clima.
La valutazione si concentra sul rendimento, i criteri di giudizio non vengono condivisi e mancano di specificità. Molte realtà sportive chiedono di esprimere una valutazione complessiva, senza aver prefigurato obiettivi e senza aver concordato preliminarmente linee guida e significati associati agli indicatori a disposizione. L’umanizzazione va ribadito, non è un prodotto, ma un processo. Gli aspetti rischiosi che abbiamo trattato precedentemente se non considerati concorrono a configurare situazioni disumanizzanti.
Essere tesi alla umanizzazione nel calcio rimanda alla lezione sempre attuale di Bordieu (1992), che incoraggia a riflettere sulla modalità di produzione della conoscenza, che richiede costante rinnovamento e criticità.
Paradossalmente occorre essere capaci di costruzione e distruzione del proprio sapere, dei propri strumenti e modelli, al fine di costruire un sapere “scomodo”, sempre rinnovato, capace di guardare a problemi vecchi con nuovi occhi, con le parole dell’autore “si tratta di produrre, se non proprio un uomo nuovo, per lo meno un nuovo sguardo”.
L’antidoto alla produzione di un sapere vuoto è la capacità di forzarsi a cambiare, introdurre novità; anche quando abbiamo la fortuna di sostare per anni in un medesimo contesto, dobbiamo forzarci di inserire del nuovo, che sia una persona, un’esperienza o una sperimentazione, per non riproporre costantemente noi stessi, per arricchire le nostre idee, per non preservare equilibri fittizi, zone di comfort, rivitalizzando così la nostra capacità di pensiero.
Questo indubbiamente è la conditio sine qua non per poter cogliere ciò che si snoda come processo di umanizzazione versus di disumanizzazione.
DUE STORIE
Non c’è nulla di più esplicativo che ripercorrere una storia… tra tante ne ricordiamo due.
La prima storia è la storia di Jordan, una giovane promessa del calcio… quattordici anni. Per i dirigenti è il futuro di un’importante squadra di serie A italiana, predestinato al successo. Viene presto scelto come testimonial da importanti brand sportivi, per sponsorizzare i loro prodotti.
Il web amplifica la sua notorietà, si diffondono le immagini del ragazzo che palleggia esibendo sé stesso e il proprio talento come una star del circo. Negli ultimi anni gioca in totale due partite nella Liga spagnola e nel 2017 il suo valore di mercato si è ridotto esponenzialmente rispetto alla quotazione di partenza agli esordi della sua carriera. Oggi gioca in serie B, in Italia, senza aver ancora messo piede in campo. Il ragazzo è stato esposto dagli sponsor senza scrupolo ai media, è stato caricato di aspettative di successo che in larga misura non dipendevano da lui e che non avrebbe potuto controllare; non ha nemmeno potuto contare sulla propria famiglia, ingenuamente collusa e coinvolta nel surriscaldamento emotivo che provoca il rapido successo, e che non ha rivestito il fondamentale ruolo di protezione dal fallimento.
Questa è una storia di disumanizzazione, non solo per l’esito indesiderabile della traiettoria regressiva della carriera del ragazzo, ma per l’uso strumentale del suo talento, delle sue emozioni e dei suoi sogni, per l’impatto sulla sua storia personale e la difficoltà a non identificarsi con nuove possibilità (vissute come un ripiego dal valore ridotto che lo avrebbero fatto diventare un essere umano di serie B, responsabile del suo insuccesso).
La seconda storia ripercorre invece il viaggio di un giocatore di origini africane, adottato da una famiglia italiana, che ha iniziato a giocare in un club di serie A all’età di sedici anni.
Quando era molto piccolo Abdek era considerato un grande talento, era più precoce dei suoi coetanei,…si saprà che una operatrice nell’orfanatrofio , lo aveva incoraggiato a dire di avere quattro anni in meno, per facilitare la possibilità di una adozione.
Il giovane calciatore si suiciderà all’età di 20 anni. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, guardando nella storia di Abdek ci sono molteplici segni di umanizzazione. La società calcistica ha sostenuto e accompagnato interamente il tortuoso percorso del ragazzo, inviandolo a servizi specializzati in adozione, assicurandogli il sostegno di una psicoterapeuta quando per motivi familiari si dovette trasferire in un’altra città, trovandogli una squadra dove inserirsi e rimanendo presente nella sua vita.
Negli ultimi quattro anni aveva dichiarato sempre che la musica e il calcio lo hanno aiutato moltissimo.
I media hanno speculato sulla vicenda, alimentando un crudele cannibalismo mediatico, sostenendo che il suicidio fosse stato indotto dall’allontanamento da parte del club sportivo, che il suo percorso fosse stato segnato da episodi di razzismo e isolamento. I genitori sono intervenuti rilasciando un’intervista in cui hanno riferito che il calcio non aveva fatto altro che aiutare il figlio, e che nemmeno il razzismo fosse la causa del suicidio. Hanno spiegato invece che crescendo, nel ragazzo, si erano riaffacciate prepotentemente emozioni negative, legate all’adozione, alle sue radici fragili, alla povertà che aveva vissuto.
Cosa ci hanno insegnato queste due esperienze? Che senza comprendere il processo, la storia nel suo dispiegarsi, è difficile leggere gli esiti e addirittura fuorviante. Non è aspetto puntuale ed unico ma più una linea che si dispiega via via e che riusciamo a vedere solo dando e consentendoci tempo…CONTINUA…

BIO: Chiara D’Angelo è coordinatore del Master di secondo livello in Sport ed Intervento Psicosociale e ricercatore presso la facoltà di Psicologia dell’Università del Sacro Cuore di Milano, docente di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. In termini di ricerca scientifica i suoi principali interessi vertono su allenatori, manager sportivi e percorsi formativi che lavorano a supporto delle competenze relazionali di questi professionisti; sullo sviluppo del talento nello sport giovanile; sulle transizioni di carriera nello sport( fine carriera, junior to senior transition, dual career); sulla progettazione e la valutazione di efficacia di progetti che usano lo sport come strumento di inclusione sociale (Sport Development Programs); sullo sviluppo professionale dello psicologo in ambito sportivo.