Nella storia del giornalismo sportivo italiano la più acuta rivalità di cui si abbia memoria recente interessò Antonio Ghirelli e Gianni Brera. Due capiscuola che, dagli anni ’50 ai ’90 del Novecento, ingaggiarono un infinito “derby” ideologico e Sud contro Nord sul modo di guardare al calcio, leggerlo e interpretarlo nelle sue strutture storiche e tecnico-tattiche.
Da un lato il difensivismo lombardo (Brera), dall’altro l’offensivismo napoletano (Ghirelli). Divisioni radicali sfociate in velenose polemiche sulla stampa e in una famosa querela intentata da Ghirelli contro Brera nel gennaio 1961.
A far da spartiacque nel rapporto fra i due fu il 1954. La ragione è presto detta: quell’anno vide l’uscita della più celebre opera d’argomento sportivo firmata da Ghirelli: Storia del calcio in Italia. Ponderoso tomo di 470 pagine, con una copertina gialla che in primo piano riproduceva la classica rovesciata di Carlo Parola in Fiorentina-Juventus del 15 gennaio 1950, che introdusse dei canoni del tutto nuovi nell’ambito della nostra storiografia calcistica. Vale a dire il superamento di ricostruzioni sin lì poco o nulla documentate, tendenti al mito e dal tono pomposamente retorico. A segnare una profonda novità fu anche la casa editrice che la pubblicò: l’impegnata Einaudi di Torino. Una prima volta da parte di un prestigiosa marchio sempre segnalatosi per tutt’altro genere d’opere di grande rilievo letterario o politico.
Ma che cosa rendeva tanto apprezzabile quella Storia del calcio in Italia? Passati da allora molti decenni, reputandone ancora sostanzialmente valide le linee, lo storico inglese John Foot ne indicò questi principali pregi:
Antioni Ghirelli – scrisse – rivoluzionò il modo di scrivere di sport negli anni Cinquanta pubblicando la prima vera storia del calcio. Questa si basa su serie ricerche storiche, nonostante sia scritta in un semplice stile giornalistico. Ghirelli era un uomo di sinistra, e il suo orientamento politico non passa inosservato nella sua opera, che si può considerare una pietra angolare per tutti gli storici del calcio, un punto di riferimento essenziale, grazie alla sua precisione e attenzione ai dettagli.
Per Foot si trattava quindi d’un testo che coniugava efficacemente la verve della narrazione giornalistica al rigore dello storico, senza nascondere il proprio orientamento politico. E il tutto non perdendo in obbiettività, anzi andando oltre l’impostazione smaccatamente fascista e di regime della letteratura precedente. Un’opera che, in definitiva, inquadrava l’evolvere del calcio italiano nelle diverse stagioni sociali, politiche ed economiche vissute dal Paese rendendone una sintesi efficace e persuasiva.
Al volume ghirelliano, Brera nel 1975 contrappose per i tipi di Bompiani una sua Storia critica del calcio italiano di taglio assai diverso e postasi da subito a suo termine di confronto. Una risposta sul come “leggere il calcio”, le cui premesse risalivano al medesimo 1954 del saggio dell’Einaudi.
Per ammissione di Brera fu infatti in quell’anno che apprese dal calcio realista e ruvido degli “uruguagi” la lezione solo all’apparenza paradossale di <<quanto sia opportuno, quando si subisce un gol, difendere la sconfitta>>. Il suo credo calcistico, da cui non tornerà più indietro, prese le mosse da questo concetto.
A detta di Brera la debolezza dell’analisi di Ghirelli consisteva innanzitutto nell’assenza “qualunquistica” d’un approccio critico al calcio. Ghirelli non esercitava questa essenziale funzione in ragione della sua modesta cultura calcistica, gli dava in pratica dell’intellettuale che si occupava dilettantisticamente di football, e la sua Storia del calcio in Italia finiva così col rivelarsi una seriale “parafrasi di risultati”.
Si limitava semplicemente a seguirne lo sviluppo temporale/evenemenziale, poiché l’autore napoletano, nel giudizio di Brera, non possedeva alcuna, solida, idea di calcio. Ciò che egli, al contrario, rivendicava con uno spirito militante che talora sfociava nel “dogma ideologico”.
In quel suo “pensiero unico” fondato sul cosiddetto “calcio all’italiana”. A questo riguardo il giornalista di San Zenone Po, con quella malcelata presunzione che lo contraddistingueva, non si tolse mai dalla testa che Ghirelli fosse privo delle competenze basilari minime indispensabili a interpretarlo. Era un naif del gioco del pallone. Parimenti Brera, all’importanza attribuita da Ghirelli al contesto socio-politico, sostituì il peculiare rilievo assegnato, oltreché agli elementi tecnici e tattici, ai prerequisiti antropologici ed etnici. Era questa, a suo parere, la piattaforma sulla quale inserire ogni successiva analisi.
Tale punto di vista l’aveva maturato quando Bruno Roghi, il direttore de “La Gazzetta dello Sport”, nell’agosto 1945 gli aveva affidato sulla “rosea” le cronache non del calcio bensì dell’atletica leggera. E nel corso di questa “gavetta” atletica aveva iniziato ad elaborare le sue, invero abbastanza immaginifiche, teorie etno-antropologiche che in seguito avrebbe applicato al football. Eccone un esempio tratto da Storia critica del calcio italiano:
Il centro-sud al di sotto della Toscana ha sempre dato pochissimo allo sport nazionale, ancor meno al calcio […] I soli a produrre buoni elementi sono i friulani e in parte i romagnoli, ai quali si adeguano i toscani. La prevalenza fra i calciatori è ancora dei settentrionali e dei toscani, pochi dei quali sono mediterranei.
L’ondata meridionale (una vera e propria “Aufsuedung”) incalza e in certo modo spiega il travaglio del vivaio, mai tanto sollecitato a produrre. Purtroppo, non è che i mediterranei vadano famosi per le loro qualità muscolari e propriamente atletiche. Sono di antica intelligenza e prontissima intuizione. Chi vuol indurre sull’avvenire del nostro calcio, può farlo rischiando poco. Il tachipsichismo dei meridionali non sembra fatto per esaltarne la tenacia nell’impegno e le virtù agonistiche. Non serve dire che queste conclusioni, per vero inficiate dall’ancor breve durata del fenomeno, vengono prese a comodo pretesto dai demagoghi.
Parlare di razze è peccato come disquisire, quattro secoli or sono, di protesta religiosa. Gli uomini sono tutti eguali… ma si differenziano per l’ambiente. Che è ovvio come dire: questa è una manciata di soldi buoni: solo che in essa figurano monetine di rame e altre, non piccole, di metalli preziosi.
Da questi assunti discendeva che una popolazione come l’italica dalla complessione morfologica inferiore a quella degli anglosassoni e dei nordici, storicamente povera e affamata, dovesse per forza di cose far di necessità virtù sfruttando ciò che le misere risorse fisiche e alimentari gli concedevano.
Ovvero, nel calcio dovesse privilegiare la difesa rispetto all’attacco, e conseguentemente colpire gli avversari, più dotati e meglio nutriti (ciò che in chiave proteico-marxista Brera chiamava “plus-calore”), con degli attacchi improvvisi alle spalle. In buona sostanza bisognava arrangiarsi coll’esistente, prendere piena coscienza dei propri limiti: questa, per il “Gran Lombardo”, era la vera natura/identità del nostro calcio.
Questo, era l’autentico significato della sua ideologia calcistica basata su “catenaccio e contropiede”, il nocciolo del tanto vituperato, all’estero, “calcio all’italiana”. Ma non solo all’estero. Anche da Ghirelli, secondo il quale <<la giustificazione che il critico>> lombardo dava a una tale interpretazione del gioco affondava <<le sue radici in una ideologia>> che sfiorava il razzismo.
Accuse gravi e sempre respinte al mittente da Brera che, viceversa, in tutta la sua produzione pubblicistica ribadirà sempre come pure nel calcio andassero genialmente massimizzati alcuni tratti tipici dell’indole e della mentalità del Paese. Nello specifico si dovessero esaltare il temperamento e l’astuzia degli italiani: quel giocare o “fare” all’italiana che ha a lungo continuato a esser inteso non unicamente alla stregua d’un efficace modulo calcistico, ma altresì quale espressione d’una tendenza utilitaristica e machiavellica della nostra società nazionale. Fin dal 27 aprile 1956, in uno dei suoi primi articoli (“Una lezione di realismo”) apparsi sul quotidiano milanese “Il Giorno”, riferendosi a una partita fra Italia e Brasile rese plasticamente questa filosofia:
Ora, perché nasconderci che molte partite abbiam voluto perdere o non abbiamo vinto per mancanza di idee tecnico-tattiche veramente all’altezza delle nostre possibilità di vivaio? In pochi andiam lottando da anni per imporre alcuni elementi che ci sembrano di una evidenza palmare.
La storia calcistica del nostro Paese non ha insegnato nulla a chi non s’accorgeva di come e perché vincesse la nostra celeberrima nazionale. Gli argomenti sono noti e non vale insistervi. Oggi la resipiscenza è solo degli onesti. Alcuni prigionieri del sogno ritornano alle frattaglie (tra cui il cuore) per spiegarsi le trepide vittorie degli azzurri. La realtà è che i tecnici ufficiali hanno capito come la sola tattica possibile agli italiani sia la difesa in forze e il contropiede.
Stando arroccati in difesa e sfruttando le capacità di scatto dei nostri attaccanti (che è grande) possiamo battere e perfino umiliare qualsiasi avversario. A San Siro con il Brasile abbiamo avuto la conferma di Roma e Stoccarda […] La Nazionale gioca secondo le sue possibilità e lascia cantare le cicale. Abbiamo uomini per il contropiede e, perfezionando meglio qualche schema, li abbiamo per il centrocampo […] Si badi ai titoli delle nostre vittime, e poi si consideri se è giusto disquisire, come ancora si fa, sul successo delle tattiche.
Brera approntò il suo pensiero difensivista quando l’Italia era uno stato pre boom e “miracolo economico”, ancora più contadino che industriale. Lui medesimo, con le sue fortissime radici padane, s’identificava con quell’Italia costretta a cavarsela con poco. Non stupisce dunque che un brillante studioso dell’età contemporanea, Sergio Luzzatto, nel commentare la filosofia di Brera l’abbia riesaminata proprio alla luce di una visione eminentemente storica:
Gli scritti calcistici di Gianni Brera – ha notato – meritano di essere letti e riletti non soltanto per la straordinaria qualità dello stile, ma proprio per il carattere datato di un “calcio all’italiana”.
Una teoria che dice tanto dell’epoca in cui fu messa a punto, tra gli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso. Quando gli italiani si sentivano stanchi e malnutriti, piccoli e deboli, ma sentivano anche di poter crescere con le loro armi di sempre. Più l’astuzia che la prestanza. Più la modestia del gioco di rimessa che l’arroganza del calcio totale. Più Nereo Rocco che Arrigo Sacchi. Più la Democrazia Cristiana che Forza Italia.
Questa rivisitazione introduce un altro nodo che, nel complesso rapporto fra Brera e Ghirelli, è doveroso affrontare: conservazione versus modernità. Brera non derogò giammai da quella sua idea di calcio che apparteneva, come ben spiegato dal Luzzatto, all’Italia lacera e da ricostruire del secondo dopoguerra.
In tal senso era a suo modo un conservatore, giacchè il football che propagandava traeva alimento da una nazione fuoriuscita da un conflitto in cui era stata duramente sconfitta e da una simile lezione storica, su un campo da calcio, doveva trarre spunto per trincerarsi e salvare il salvabile anziché lanciarsi in “donchisciottesche” offensive destinate a un logico e inesorabile fallimento.
Ghirelli col suo calcio inteso quale <<furibonda follia>> e <<amore per la vita>> esprimeva all’opposto una sorta di slancio romantico e ottimistico verso il nuovo che voleva lasciarsi alle spalle il passato e guardava fiduciosamente alla modernità.
Brera si poneva nella tradizione di Vittorio Pozzo attualizzata da Rocco, il “Paron” con cui dentro e fuori dagli stadi se l’intendeva a meraviglia, Ghirelli mirava a degli orizzonti più internazionali che sarebbero completamente maturati con l’avvento del calcio olandese. Detto ciò, nella breriana Storia critica del calcio italiano riferimenti espliciti a Ghirelli non se ne fanno. Tuttavia, leggendo più attentamente fra le righe, è possibile coglierne uno abbastanza nitido: Questo:
La situazione della critica in Italia, è oggi la seguente: al “Giorno” e al “Guern Sportivo” prevalgono le idee dell’autore di questo libro; alla “Gazzetta” è diventato direttore un amico, già capo della direzione romana al tempo della mia direzione, Gualtiero Zanetti […] Gualtiero è difensivista e segue il mio stesso metodo. Avversari miei e suoi di lui in quanto direttore della “Gazzetta”, tutti gli altri quotidiani sportivi. Diviso il resto della stampa e talora su posizioni di ambiguo opportunismo.
Il pavese rimaneva sul vago, ma è legittimo pensare che tra i principali oppositori al suo “catenaccio e contropiede” annoverasse Ghirelli e Gino Palumbo, anch’egli partenopeo verace e col quale giunse a vie di fatto in una clamorosa scazzottata allo stadio di Brescia. Due nemici dichiarati ai quali affibiò la definizione caustica di “Dioscuri del Vesuvio”.
Tant’è, pure a Palumbo rimprovererà la mancanza di ogni contenuto critico al pari del sodale concittadino. <<Ghirelli – asseriva Brera accomunandoli – è molto intelligente, napoletano, scrive in un italiano facile. Ma l’impostazione scientifica gli manca>>. Per lui, Ghirelli e Palumbo, eccedevano in <<letteratura>> e <<sentimentalismo>> che servivano a coprire la loro incultura calcistica e l’incapacità di analizzare criticamente la partita.
Corollari d’una siffatta incompetenza erano l’amore per l’offensivismo tout court, e individualmente per il numero “10” del Milan Gianni Rivera. “L’abatino” simbolo dei limiti e delle contraddizioni del football italiano. Il calciatore che a suo parere rappresentava antropologicamente l’archetipo dei vizi del Bel Paese, tacciandolo d’essere <<un finto, che non possiede potenza né impegno. E’ un finto, uno stilista, ma in definitiva un giocatore da amichevoli. Un atipico: non rientra in nessuna categoria o norma […]
In Rivera trovi il talento ma non il carattere. Come negli italiani in genere. L’italiano è furbo, malizioso, intelligente e senza impegno: perciò Rivera è un bellissimo tipo di italiano. E’ la ragione per cui è tanto amato dalle folle, che si riconoscono in lui>>.
L’insulso attaccare tutto <<anema e core>>, <<pizza e mandolini>> sposato da Ghirelli, al punto da definirlo il 10 dicembre 1960 su “Il Giorno” un “Pulcinella all’attacco”, a Brera appariva un effetto della sua napoletanità in cui prevaleva la mera fantasia, un certo romanticume. All’inverso per Brera il risultato perfetto era dato da un saggio 0-0: l’esito di un equilibrio di forze votate a salvaguardare l’inviolabilità sacra della porta. Un annullarsi reciproco conseguito attraverso l’uso consapevole dei mezzi su cui far conto.
Analogamente, l’incontro più importante della domenica calcistica per il pragmatismo breriano non era costituito da un Milan-Inter, Torino-Juventus e Roma-Lazio bensì quello disputato dalle due squadre che, sommando i loro punti in classifica, davano il maggior quoziente. In conclusione le posizioni calcistiche di Brera e Ghirelli rimasero sempre inconciliabili. Antitetiche e antagoniste. I due si detestavano amabilmente anche sul piano personale, non v’è dubbio. E non persero mai occasione per punzecchiarsi attraverso i loro giornali. Brera gli fu sicuramente superiore per inventiva linguistica ed espressività, creò una neo-lingua del calcio e dello sport tutta sua e inimitabile; Ghirelli si dimostrò più “politico” e capace nella direzione delle varie testate attraverso cui si sviluppò la sua carriera (“Tuttosport”, “Corriere dello Sport”).
Il credo calcistico di Brera mostrava delle crepe soprattutto nelle elucubrazioni antropologiche ed etnologiche, debolissime sul piano scientifico, e in cui però si sforzava di credere cecamente; Ghirelli, di fatto, si limitava a esaltare la bellezza estetica del gioco (l’”apollineo” Rivera) senza approfondirne a sufficienza gli aspetti tecnici. Il loro dualismo va infine ricondotto alla storica frattura fra Nord e Sud del Paese. Esso costituì una plastica rappresentazione, riflettentesi sullo stesso calcio, del mosaico di culture regionalistiche tipico della società italiana. Di quell’unificazione imperfetta di cui si portano ancora oggi i segni.
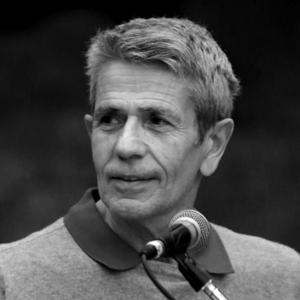
BIO: Sergio Giuntini, presidente della Società Italiana di Storia dello sport, ha insegnato presso le Università di Verona, Milano Statale e Cattolica, Roma Tor Vergata. Tra i suoi più recenti saggi: “Storia critica del Milan 1899-2019” (Sedizioni, 2021); “Vincenzo Torriani e l’Italia del Giro” (Prospero Editore, 2021); “Storia dello sport femminile in Italia 1945-2020” (Aracne Editrice, 2021); “Lo sport imbroglione. Storia del doping da Dorando Pietri ad Alex Schwarzer” (Ediciclo, 2022).














